|
Costantinopoli nel 1453, catena sul Corno d’Oro
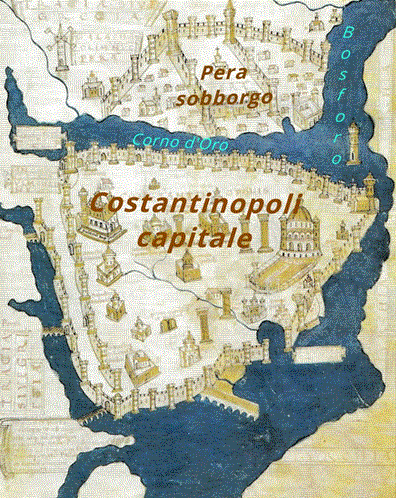 Sono evidenziati il sobborgo di Pera, il Corno d’Oro, il Bosforo, il centro di Costantinopoli. Costantinopoli, o Bisanzio, capitale dell’Impero Bizantino, diviene potente con la fine di Roma antica: è il centro strategico dei commerci tra Oriente ed Occidente, è erede della grande cultura greco-romana. Dopo circa mille anni dalla fine della prima Roma, va incontro a definitiva caduta questa grande capitale, nata come seconda Roma. Autori del tracollo sono i turchi, popolo asiatico che da secoli segue una politica di espansione, diffondendosi in Asia Minore e nei Balcani, fin quando - nel 1453 - con moto avvolgente stringe a tenaglia la ricca capitale bizantina fino alla resa. Costantinopoli non è nuova ad esperienze cruciali, come l’attacco degli arabi del VII sec. e la politica aggressiva dei veneziani nel XIII sec., tuttavia le sue cadute e rinascite l’hanno inevitabilmente indebolita, facendola crollare di fronte alla forza militare dei turchi ottomani. Questi ultimi, da vincitori, mantengono Costantinopoli capitale del loro impero, attribuendole il nome di Istanbul. Cadendo la città cosmopolita, collocata sul Bosforo, vengono travolti non solo gli abitanti locali, ma una moltitudine di commercianti e artigiani e studiosi che possono venire da Venezia, come da Genova, dai Balcani come da molte altre regioni. Il mondo occidentale, diviso da Costantinopoli da antica rivalità e da un contrasto religioso – cattolici contro ortodossi -, non si è adoperato nel soccorso dell’Impero Bizantino, che è sempre un impero cristiano assalito da musulmani. Tuttavia la caduta della città viene vista come un fatto epocale, aggravato dalle testimonianze di quanti hanno vissuto la fine di Costantinopoli, preceduta da un lungo e duro assedio e seguita da un terribile eccidio. Le testimonianze parlano di un’aggressione musulmana compiuta con una straordinaria potenza d’urto. Secondo uno scritto di Enea Silvio Piccolomini, futuro Papa Pio II, sono messi in campo turco almeno centocinquanta mila uomini, compresi diecimila giannizzeri (truppe scelte), e inoltre viene impiegata una flotta di circa centocinquanta navi di vario tonnellaggio: un numero di armati enorme per quei tempi. I piani militari dei turchi sono proprio studiati per una città ben protetta per via terra da un sistema di fortificazioni e per via mare dall’ostacolo che, come dice il Piccolomini, è “l’enorme catena che il veneziano Bartolomeo da Soligo aveva teso all’imboccatura del Corno d’Oro, fra la Torre di Sant’Eugenio e un’altra situata sulla riva opposta, presso la fortezza di Galata (o Pera)”. Tuttavia il sultano Maometto II, a capo degli ottomani, segue l’audace tattica di far transitare per terra settantadue biremi che devono passare dal Bosforo al Corno d’Oro – come compare nell’illustrazione soprastante -. Vengono utilizzati fusti di legno opportunamente lubrificati, su cui sono trascinate le imbarcazioni che da un’area collinare scendono nel Corno d’Oro, seminando stupore e terrore. Maometto II è anche molto attento alle conquiste tecnologiche dell’Occidente, si rivela più abile del suo rivale, l’imperatore bizantino Costantino XI Paleologo. Maometto II ricorre ai servizi di un ingegnere ungherese di nome Urban, buon costruttore di cannoni, che già aveva contattato Costantino senza concludere un accordo. Sono proprio le cannonate di una “grande bombarda fusa da Urban” che terrorizzano i bizantini assediati e che colpiscono incessantemente aprendo brecce nelle mura di Costantinopoli, che per fama dovrebbero rappresentare un baluardo invalicabile. |
 |